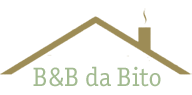Isola di Diomede
Isole di Diomede
Nell’antichità, le Tremiti erano chiamate Isole di Diomede perché, secondo una leggenda, vi morì e vi fu sepolto l’eroe greco Diomede che vi era approdato durante il suo viaggio di ritorno dalla guerra di Troia.
I compagni dell’eroe, narra ancora la leggenda, furono invece tramutati da Venere in uccelli marini: le « diomedee ».
L’imperatore Augusto (e questo è un fatto storico) esiliò alle Trèmiti la perversa nipote Giulia che vi rimase 20 anni e vi mori.
Ma le più interessanti vicende storiche di queste isole sono collegate alla celebre Abbazia fortezza di San Nicola che giganteggia sull’isola omonima.
Dice lo scrittore Max David, che ha dedicato alle Trèmiti alcuni articoli pubblicati sul giornale « II Corriere della Sera »:
Abbazia di San Nicola
« L’Abbazia di San Nicola, fondata nell’VIII secolo, appartenne in un primo tempo ai monaci benedettini che vi giunsero dalla celebre Abbazia di Montecassino. Non si può dire che quei fraticelli fossero delle paste di uomini. La vita stessa che erano costretti a fare, soli, in mezzo al mare, fra pirati turchi e pirati dàlmati, li rendeva dei tipi quanto mai difficili.
Poco dopo essersi insediati nell’isola, si proclamarono indipendenti da Montecassino e si costituirono in repubblica, o qualcosa di simile. Immediatamente, papa Alessandro II promosse un’inchiesta e inviò alle Trèmiti un certo abate Desiderio il quale, avendo constatato che proprio ìl padre superiore, il padre Adamo, era stato il promotore della rivolta, lo sostituì con tale abate Trisimondo.
Ma i « dolci » fraticelli si ribellarono anche a. Trisimondo. Costui, però, domati gli insorti, si ribellò a sua volta a Montecassino che mandò giù a sistemare le cose un altro frate, padre Ferro.
Padre Ferro, come i suoi predecessori, non tardò ad essere preso dalla voglia dell’indipendenza e insorse anche lui contro Montecassino. Finché anche il papa perdette la pazienza e nel 1236 fece espellere dalle Trèmiti i Benedettini, sostituendoli coi Cistercensi. Questo per dire che razza di uomini erano gli abitanti di San Nicola ottocento anni or sono.
I Cistercensi, invece, erano dei sant’uomini, ma come sempre succede nelle cose di questo mondo, toccò proprio a loro, se vi furono colpe e malefatte, di scontarle per tutti. Fu un ‘fattaccio che per trovare l’uguale bisogna risalire al cavallo di Troia.
Dopo duecento anni di amministrazione benedettina, l’abbazìa aveva accumulato ricchezze favolose, tesori immensi e grandi proprietà terriere e immobiliari anche sulla riva gargànica che sta di fronte alle Trèmiti. Sulle due coste adrìatiche era noto a tutti che l’Abbazia fortezza di San Nicola nascondeva una colossale for-tuna ma, mentre dalla parte dell’Italia a nessuno passava per la mente di attaccare l’isola e di depredare i suoi frati, dalla parte opposta invece, nella Dalmazia, i marinai dei dintorni di Spalato e in particolare quelli di Almissa, decisero di intraprendere un’azione corsara contro l’Isola di San Nicola e contro i frati.
L’impresa, si sapeva, non sarebbe stata facile, anche se i Benedettini non c’erano più. Si sapeva che le fortificazioni rendevano inespugnabile l’isola e non si era ben sicuri che Ì Cistercensi fossero molto diversi, come spìrito guerriero, dai Benedettini di un tempo.
Coi i Benedettini ci sarebbe stato poco da fare. Erano furbi e coraggiosi, e poi erano dei politici. Avevano sgominato i Turchi alleandosi ai Dàlmati, poi avevano vinto i Dàlmati associandosi ai Turchi e infine, coi Turchi e i Dalmati insieme, avevano dato addosso agli Slavoni. Ma di che pasta fossero i Cistercensi nessuno ancora Io sapeva.
Ad ogni modo, i corsari di Almissa, pur dando inizio alla loro impresa con alcune barche da guerra e con un numero di uomini sufficiente, si proposero di agire più con la furbizia che con la forza.
In un giorno imprecisato del 1321, essi arrivarono, indisturbati, alla rada di San Nicola.
Due uomini, che sembravano pescatori, scesero subito a terra e, facendosi a .piedi tutta la lunga rampa che anche oggi si deve percorrere per arrivare dalla spiaggia all’abbazia, si presentarono al padre superiore dicendosi cristiani. Era successa una disgrazia in mare, dicevano. Un loro compagno era motto all’improvviso e ora bisognava celebrare le sue esequie alla maniera cristiana.
I due dàlmati vestiti da pescatori singhiozzavano come bambini, raccontando la storia del loro compagno morto improvvisamente in mezzo al mare. Se fossero andati avanti un altro poco il padre superiore, certo, si sarebbe messo a piangere anche ]ui. Era un cìstercense, non un benedettino.
Egli, infatti, si commosse presto e dette senz’altro le disposizioni necessarie. Ordinò a sei frati che accendessero sei ceri e che scendessero giù alla spiaggia per ricevere la salma del cristiano. Intanto, nella chiesa, gli altri frati avrebbero preparato un bel catafalco.
Era ormai tramontato il sole (i pirati avevano studiato l’ora più opportuna per la riuscita dello stratagemma) e i sei fraticelli che scendevano a due a due verso la spiaggia illuminavano coi brevi bagliori dei loro ceri le poderose fortificazioni.
Quando i sei frati giunsero sulla riva del mare, la notte era ormai fatta e si presentò ai loro occhi una scena davvero toccante. Le torce illuminavano le tre barche guerriere affiancate con la prua al vento. Sulla poppa della nave di mezzo stava la bara del povero « morto », che era grezza, di quattro assi inchiodate. Le ciurme erano in piedi sulle murate e nessuno avrebbe detto che si trattava di ciurme corsare della Dalmazia, tanto era intenerito e pietoso il loro aspetto intorno al corpo del compagno scomparso.
I frati dettero un’occhiata alla cassa, trovarono che tutto era a posto e consentirono al suo trasporto sulla spiaggia.
Ora bisognava disporre per la processione, e anche a questo pensarono i sei frati.
Un primo gruppo di corsari apriva il corteo. Veniva poi la cassa del « morto » portata a spalle da alcuni marinai. Seguivano i sei fraticelli, sempre coi loro ceri accesi, e il ,,corteo era chiuso dalla restante ciurma di cui ogni uomo recava una fiaccola con la mano destra.
La mano sinistra tutti la tenevano in tasca, ma il particolare sfuggi ai sei fraticelli. Infatti essi pregavano con la massima compunzione, e anche la ciurma pregava, sia pure a modo suo, mentre qualcuno dei corsari piangeva sommessamente o era agitato da profondi singulti.
L’eco dei pianti e delle giaculatorie arrivava fin su all’abbazia dalle cui mura tutti i frati del convento, sporgendosi verso il mare, seguivano l’avvicinarsi del corteo, alla luce delle fiaccole, lungo la ripida scarpata. Per loro, un morto forestiero nell’isola era una grande novità; era un fatto che prima non era mai successo.
Il rito cristiano della benedizione della salma era da poco iniziato nella chiesa dell’abbazia, quando uno della masnada emise un breve ed acutissimo grido di dolore. Era invece, per quei pirati, il segnale di attacco. Le torce furono spente all’improvviso e nel tempio rimase solamente la luce dei ceri dei frati. Poi, la bara che avrebbe dovuto contenere il morto, si scoperchiò violentemente, ne uscì un demonio di corsaro vivo che non avrebbe potuto essere più spaventoso a vedersi. Ed ebbe inizio il massacro.
I frati erano inermi, mentre i corsari erano armati anche più del necessario. La mano sinistra che nascondevano in tasca, stringeva, infatti, un pugnale.
Alla carneficina sembra che siano riusciti a sfuggire due soli cistercensì, mentre quasi tutto il favoloso tesoro di San Nicola finì nelle stive delle navi corsare.
Per più di trentanni, nessuno, né frate, né laico, ebbe l’ardire d’accostarsi alle Isole Trèmiti e ci volle tutta l’autorità dì papa Gregorio XII per convincere l’Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi a mandare a San Nicola una prima pattuglia di audaci »,
I Lateranensi, per non correre a loro volta gravi rischi, trasformarono il convento in una fortezza che resistette, il secolo seguente, ad un assalto della flotta turca. L’abbazìa, inoltre, estese i suoi possedimenti nella Puglia, nel Molise e nell’Abruzzo, assoggettando al proprio dominio città, castelli con laghi, boschi e campagne. Decine di navi di proprietà del convento andavano e venivano da questi possedimenti alle Trèmiti, cariche dì ogni ben di Dio.
Poi, tanta potenza a poco a poco diminuì, e quando nel 1789 Ferdinando IV di Borbone soppresse l’abbazia, i Lateranensi se ne andarono e per qualche tempo le isole rimasero deserte.
A ripopolarle ci pensarono i Borbonì inviandovi dei « lazzaroni » (vagabondi: napoletani, i quali ci si trovarono tanto bene da metter su casa. E fu in questo modo che le due principali isole dell’arcipelago, San Nicola e San Dòmino, si animarono di abitanti i cui discendenti, oggi, non sono più dei, vagabondi ma dei bravi pescatori che parlano ancora il dialetto napoletano.
Fino al 1943, tuttavia, una visita alle isole era rattristata dalla presenza di prigionieri politici ivi confinati dal governo italiano. Oggi, scomparso anche quel brano ricordo, le Isole Trèmiti, festose di colori e di luce, accolgono il turista con attrattive che, a parte i conforti e le distrazioni della vita moderna, nulla hanno da invidiare alle tanto decantate bellezze di altre isole italiane più famose.

I TESORI DI DIOMEDE di Folco Quilici
I TESORI DI DIOMEDE di Folco Quilici
Quanto nascosto nell’isola dove sto per condurvi, potrebbe essere un tesoro vero, monete, oggetti d’oro, gioielli. Lo preciso perché quando si cita un’isola mediterranea, vien spontaneo definirla un “tesoro” per la rarità delle sue bellezze. No. Narrandovi di San Nicola, nel microarcipelago delle Tremiti, parlerò di veri e propri tesori. E mi riferirò a eventi reali di pirateria in conseguenza dei quali molti beni preziosi vennero laggiù nascosti.
La piccola, calcarea San Nicola è dominata da un’imponente fortificazione; mura e pareti rocciose di un edificio un tempo ritenuto difficile da espugnare. Faticoso oggi da visitare, salendo dal mare sino ai suoi livelli superiori.
Ho affrontato la lunga scalinata protetta da spalti e merli verso l’imbrunire, passo a passo, sino alle costruzioni interne, sfiorando pietre dove sono impastati dieci secoli di storia. Parti d’una colossale opera artificiale resa imprendibile anche dalla natura: anche pareti di roccia, a strapiombo sul mare furono tagliate verticalmente per proteggere la fortezza da possibili assalti alle spalle. Occorreva difendere quanto qui veniva accumulato. Ricchezza di saccheggi ma anche donazioni ottenute in cambio della
protezione offerta a ricche famiglie delle rive pugliesi.
Pirati saraceni e dalmati nel miraggio di questi beni, s’accanirono nel tentativo d’espugnare l’isola-fortezza che al centro dell’Adriatico meridionale non difendeva solo beni in pericolo, ma anche popolazioni minacciate non solo dai furti dei saraceni, ma anche dalla loro caccia a schiavi da razziare tra i miscredenti cristiani.
I castellani non si limitarono tuttavia ad azioni di difesa. In un lungo e fosco periodo anch’essi compirono azioni di pirateria verso porti, mercati, navi da trasporto. Accumulando altre ricchezze.
Strana categoria di pirati, quella di base a San Nicola: erano monaci benedettini! Nel 1045, provenendo da Montecassino, essi avevano creato un primo monastero sull’isola, attorno alla cappella edificata nel 311 da un eremita; da allora in poi, di anno in
anno, avevano però trasformato l’Abbazia, mutando anch’essi nel tempo. Da aggregazione di gente pia a banda, tanto arrogante e ricca da pretendere l’autonomia dall’Ordine. Delirio di potenza che non poteva non preoccupare la Chiesa, anche perché attendibili voci continuavano a diffondersi su azioni più da fuorilegge che di carità; e di alleanze con i dalmati non tanto per difendersi dai turchi ma per assaltare qualunque naviglio da trasporto.
Fosca epopea che si concluse tragicamente nel 1343, quando i monaci vennero tutti trucidati da corsari slavi. Erano riusciti a far entrare nell’Abbazia inespugnabile una bara, implorando benedizione e degna sepoltura cristiana ad un compagno defunto. In quella bara avevano nascoste armi; e una volta in chiesa, all’interno delle mura, gli assaltatori, spade e coltelli in pugno, avevano compiuto la strage e razziato tutto. Forse, però, non l’intero tesoro. Secondo cronache che molti ritengono attendibili, i corsari sterminatori non riuscirono a trovare quanto giaceva in nascondigli sotterranei.
Non è un caso, quindi, se da quando le Tremiti tornarono a popolarsi anni dopo l’eccidio, sbarcano a San Nicola numerosi e accaniti cacciatori di tesori. Che non hanno mai smesso di scavare, di cercare. A mio avviso un tesoro esiste, alle Tremiti. Non è, però, una cassa di gioielli o di monete d’oro. E’ di ben diversa natura.
Nasce dal mito dell’eroe omerico Diomede. Di lui narra Omero che dopo la morte di Achille nessuno, sotto le mura di Troia, lo emulava per valore e coraggio; fu nel ventre del cavallo di legno, il finto ex voto dell’astuto Ulisse che permise ai greci di penetrare e distruggere l’irriducibile città nemica.
Per quanto forte e astuto, Diomede quando tornò in patria fu però vittima, come Agamennone, del tradimento ordito dalla moglie. Scampò alla morte e fuggì dalla sua patria per fondarne un’altra, cercandola lungo le rive dell’Adriatico, nel “paese del tramonto”, l’Hesperia (quell’Italia ancora “terra incognita”). Come per molti eventi leggendari, anche il viaggio di Diomede nel nostro mare ha un fondamento reale. Interpretando varie fonti antiche, gli studiosi d’oggi leggono le leggendarie avventure del viaggio di Diomede, come un riflesso delle rotte dei greci micenei lungo l’Adriatico. Una pagina di storia reale sulla quale si innestò la favola di un eroe.
Il suo epico viaggio si concluse quando la sua imbarcazione naufragò alle Tremiti e Diomede venne sepolto con i compagni alle Tremiti. Secondo la leggenda Afrodite, la divina protettrice dell’eroe, tramutò i suoi compagni in uccelli di mare; sono le diomedee, “berte maggiori” che nidificano nella costa, tra le rocce delle Tremiti. Il loro canto, asserivano i cantastorie antichi, doveva ricordare Diomede, ai navigatori che bordeggiano l’arcipelago. E con lui ricordare anche compagni, destinati a vegliare sulla sua tomba con canti notturni. Leggenda profondamente radicata, non solo perché nell’isola esiste effettivamente una arcaica tomba greca, a tholos, detta “di Diomede”, ma perché in quei pressi il silenzio di ogni sera estiva è rotto dalle “strida acute” levate dagli stormi di berte maggiori. Autori come Plinio, Ovidio, Strabone chiamavano le avis diomedea quell’uccello e assieme ad altri autori classici riferivano tutti di quel lugubre, notturno grido e lo interpretavano come “un pianto”.
Colonna sonora invariabile di una favola immortale. Echeggia nelle notti di primavera, nel tempo in cui le berte covano le loro uova. Soprattutto in quelle settimane si alza nel buio il loro concerto inconfondibile. Per noi un misterioso canto corale, per loro singoli messaggi sonori di scambio, tra maschi e femmine. Al momento del ritorno all’isola dopo la caccia in mare, il maschio cerca d’orientarsi; e la femmina, già a terra per covare le uova, risponde al richiamo del partner per guidarlo come con un radar al nido. Invisibile, nell’oscurità. Per quanto ancora? Le “diomedee” sono in pericolo anche se nel Mediterraneo arrivano ogni primavera in più di centocinquantamila dall’Africa.
Nel loro lungo, faticoso viaggio migratorio, affrontano non solo continui cambiamenti di condizioni meteorologiche, ma soprattutto l’insidia che cresce di anno in anno: la “posta” dei cacciatori. Molti sono africani, ma ancora di più sono gli europei, che uccidono non per fame ma per divertimento. Solo lungo le coste maltesi al momento del “passo” vengono uccise oltre
duemila berte. La strage si moltiplica con la caccia praticata in molte altre isole mediterranee. In non poche, gli abitanti hanno per di più l’abitudine di cibarsi delle loro uova, quando le berte si posano per la cova durante il periodo estivo. Solo a Linosa, dove si è compiuta una ricerca nell’arco di molti anni, gli isolani ne raccolgono dalle duemila alle quattromila. Altrove, le berte vengono uccise anche per prelevare alcune particolari penne da usare come esche per la pesca. Alle Tremiti la loro colonia per ora è salva. Poco lontana dai nidi, quella tomba sia o non sia quella dell’eroe Diomede, ci tramanda un gioiello canoro altrove ferito e disperso.
Il canto quasi umano di un popolo alato, ripetuto qui da migliaia di anni. Un tesoro di suoni sempre più raro, unico al mondo.
Folco Quilici